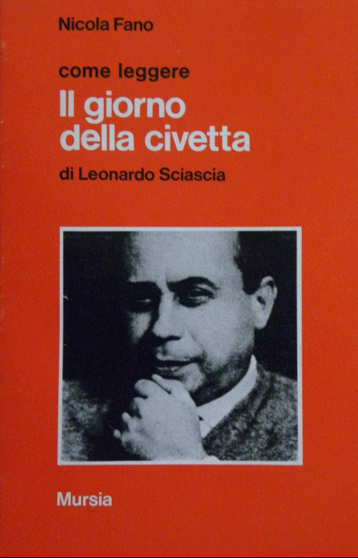 Leonardo Sciascia nacque l’8 gennaio 1921, una settimana prima che nascesse il Partito comunista d’Italia.
Leonardo Sciascia nacque l’8 gennaio 1921, una settimana prima che nascesse il Partito comunista d’Italia.
Leonardo Sciascia morì il 20 novembre 1989, dieci giorni dopo la caduta del muro di Berlino.
Leonardo Sciascia, come tutte le grandi personalità, ha saputo leggere e raccontare la società in modo magistrale. Ha visto nascere e morire il comunismo, di cui fece parte, ma non vide né nascere né morire la mafia, che seppe raccontare in tutta la drammaticità del fenomeno.
“Il giorno della civetta”, pubblicato nel 1961, fu il primo libro a svelare il funzionamento della mafia, sottolineandone i rapporti loschi con la politica e, in tal modo, trasformando il romanzo nel detonatore di un dibattito pubblico che dopo 52 anni non si è ancora sopito e che oggi si sviluppa pure nelle aule giudiziarie.
La trama. Un uomo viene assassinato mentre sale su un pullman. Tutti i testimoni oculari si trasformano in un muro di gomma sul quale è costretto a schiantarsi il capitano Bellodi che svolge le indagini. L’atteggiamento omertoso che avvolge la vicenda è la cifra morale della società.
Tuttavia Bellodi arriva all’omicida e ai suoi mandanti, i quali vengono prima fermati e presto rilasciati, fino a che il caso non viene archiviato dietro pressioni politiche di esponenti della Democrazia Cristiana, per mezzo di alibi costruiti ad arte, fino ad arrivare ad affermazioni come quella che la mafia sarebbe un’invenzione dei comunisti e che l’omicidio sarebbe l’esito di una infedeltà coniugale.
I fatti si sarebbero incaricati, nei decenni successivi, non solo di dare ragione a Sciascia ma anche di superare abbondantemente la fantasia dello scrittore sia sull’intensità omertosa, sia sulle collusioni, sia sulla immoralità dei politici e della politica, sia sul campionario di vizi umani sottoposti ad analisi.
Indelebile la suddivisione degli uomini elaborata dal padrino don Mariano Arena ed esposta al capitano Bellodi: “Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà… Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E invece no, scende ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi…E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito… E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre… Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo…”.
Già a quel tempo il padrino sapeva come gli uomini veri fossero davvero pochi in una umanità zeppa di persone indegne di qualsiasi ruolo. Alla evidente vis polemica, Sciascia accompagna l’esigenza di interrogare e interrogarsi sulla realtà, nel tentativo di decifrarla e di denunciarne i meccanismi corrotti.
Il pretesto dell’omicidio svela le intenzioni ben più vaste dell’autore, il quale inquisisce a tutto tondo i modi di porsi e i modi di vivere della società meridionale e dell’Italia intera. La questione morale sale dal romanzo e si cristallizza nella pubblica opinione due decenni prima che Berlinguer la formalizzasse. Al talento dello scrittore fa premio la lungimiranza con la quale ha saputo interpretare il carattere tipicamente italiano, arguendo che gli sforzi di coloro che lottano per la giustizia sono vani e destinati a sicura sconfitta perché l’assurdo è inattaccabile e invincibile.
Lo Stato non ha il diritto di proclamarsi innocente di fronte all’esistenza della mafia perché, in ultima analisi, sono proprio i politici i reali mandanti dell’omicidio. Sciascia si domanda: “E quale altra nozione poteva avere del mondo, se intorno a lui la voce del diritto era stata sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva soltanto cangiato il colore delle parole su una realtà immobile e putrida?”.
La mafia non è che il frutto amaro di uno Stato ingiusto che non ha permesso la crescita civile del popolo.

Commenta
Commenti