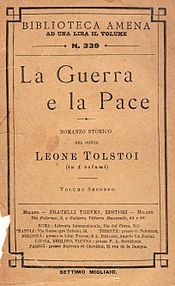 Tolstoj scrisse “Guerra e pace”, un’autentica epopea eroica, nella pace di Jasnaja Poljana tra il 1865-1869. Doveva essere in origine un romanzo breve, ma assunse poi dimensioni più vaste. In esso i fili della narrazione sono così variegati e i personaggi così numerosi e complessi da rischiare la confusione, eppure l’autore si mantenne padrone assoluto della materia. Anzi evitò la prolissità e collegò armonicamente gli artifici narrativi necessari al romanzo con un sistema ideologico di grande complessità.
Tolstoj scrisse “Guerra e pace”, un’autentica epopea eroica, nella pace di Jasnaja Poljana tra il 1865-1869. Doveva essere in origine un romanzo breve, ma assunse poi dimensioni più vaste. In esso i fili della narrazione sono così variegati e i personaggi così numerosi e complessi da rischiare la confusione, eppure l’autore si mantenne padrone assoluto della materia. Anzi evitò la prolissità e collegò armonicamente gli artifici narrativi necessari al romanzo con un sistema ideologico di grande complessità.
La maestosa epopea si annoda intorno alla vicenda di due potenti famiglie russe, i Bolkonskij e i Rostov, con il mondo dei contadini e degli umili che le fa da sfondo. Non c’è differenza nel giudizio tra i personaggi storici e quelli d’invenzione.
Risaltano nell’orditura generale alcune figure emblematiche: Pierre Bezuchov, che vaga smarrito sui campi di battaglia vestito con gli abiti di signore di campagna. Egli rappresenta l’ingenuità, la mancanza di ogni calcolo e la scoperta della vita morale “in seno all’immensa umanità del suo popolo”; Nataša, che approda alla spiritualità dell’anima, dopo una giovinezza dedita alla vita mondana e ai falsi amori; il principe Andrej Bolkonski, che soltanto sul punto di morire scopre una pace che gli sembra derivare dalla potenza creatrice di Dio. Cade in battaglia sull’altura di Pratzen “voilà une belle mort” sente dire in francese: “le voci intorno chiamavano Sire chi le aveva pronunciate. Era l’imperatore, Napoleone”.
In “Guerra e pace” Napoleone è presentato come un personaggio a tutto tondo, sebbene al suo primo apparire, ad Austerlitz, Tolstoj adotti il metodo indiretto, sperimentato già da Stendhal. L’autore lo giudica severamente, un uomo che “mai, mai, sino alla fine della sua vita, riuscì a intendere né il bene né la bellezza, né la verità, né il significato dei suoi atti”. Napoleone viene contrapposto al condottiero russo Kutuzov, l’antieroe “fiducioso interprete delle leggi naturali per cui, anche senza lampi di strategia geniale sui campi di battaglia, l’ondata napoleonica dovrà alla fine trovarsi assorbita e vinta dall’ineusaribile distesa della steppa russa, dalla costanza della gente che vi abita”.
Proprio il popolo russo è il vero protagonista del romanzo: lo spirito popolare e collettivo influisce sulla storia molto più delle ambizioni dei grandi condottieri.
Ciò che rimane dalla lettura di “Guerra e pace” è l’orrore per la guerra e il desiderio di una pace assoluta e duratura, impossibile da conquistare in ogni tempo e angolo del mondo.
George Steiner riteneva che chi ha davvero assimilato un dipinto di Cézanne non potrà più guardare una mela, o una sedia, come le guardava prima. Allo stesso modo chi ha letto “Guerra e pace”, come avviene con i grandi capolavori, non è più la stessa persona che era in precedenza. Infatti “le grandi opere d’arte ci attraversano come venti di tempesta, spalancando le porte delle nostre percezioni e investendo l’architettura delle nostre convinzioni con la loro potenza riformatrice”.
Per Sartre “la tecnica di un romanzo ci riporta sempre alla metafisica del romanziere (à la métaphisique du romancier)” e l’opera d’arte conserva in se stessa l’origine del pensiero, lo sforzo eroico dell’animo umano di imporre un ordine e una personale interpretazione al caos esperenziale.
In “Les voix du silence” Malraux afferma con convinzione che l’uomo è imprigionato “tra la finitezza della condizione umana e l’infinità delle stelle”. Solo i monumenti della ragione e della creazione artistica possono essere il fondamento della rivendicazione di una dignità trascendente nell’uomo. Longino avrebbe usato propriamente la parola “sublime”.

Commenta
Commenti