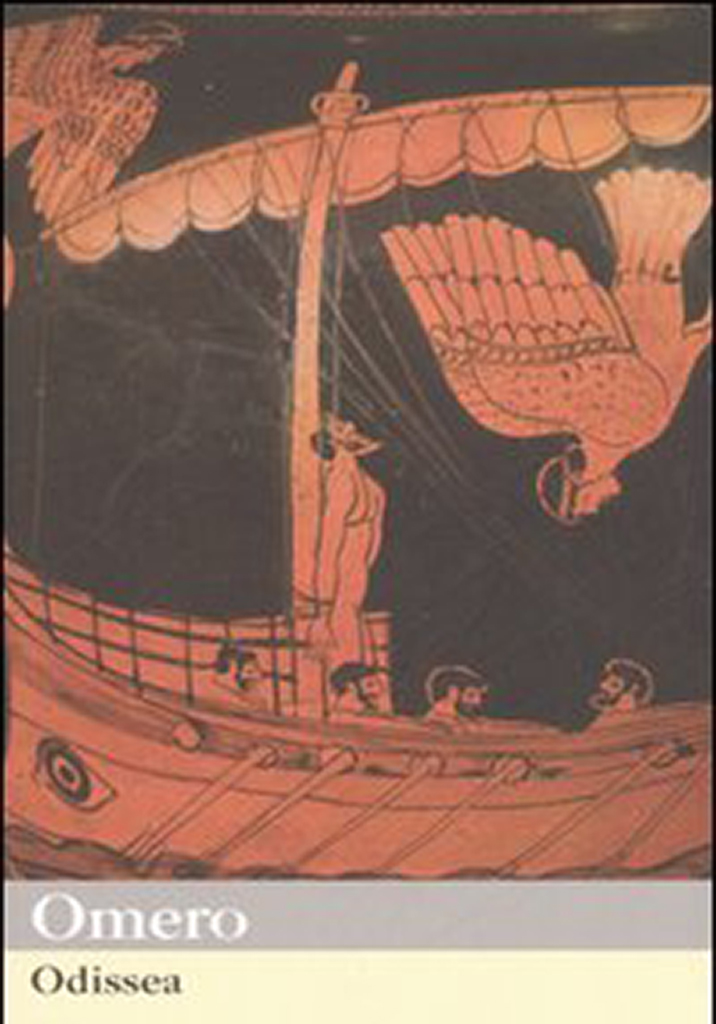 Da bambina ricordo dei versi che venivano recitati a memoria da contadini analfabeti, allora mi meravigliavo, perché non capivo come ciò potesse accadere, da dove scaturissero quei ricordi, senza che quelle persone avessero frequentato alcuna scuola. Esiste una tradizione orale, che parte dagli antichi aedi, basata sul potere della memoria. Da questa deriva la forza della parola che supera il tempo. Una voce rude fu quella da cui sentii recitare la prima volta alcuni versi dell’Odissea di Omero: “Musa, quell'uom di multiforme ingegno/Dimmi, che molto errò, poich'ebbe a terra/Gittate d'Ilïòn le sacre torri;/Che città vide molte, e delle genti/L'indol conobbe” .
Da bambina ricordo dei versi che venivano recitati a memoria da contadini analfabeti, allora mi meravigliavo, perché non capivo come ciò potesse accadere, da dove scaturissero quei ricordi, senza che quelle persone avessero frequentato alcuna scuola. Esiste una tradizione orale, che parte dagli antichi aedi, basata sul potere della memoria. Da questa deriva la forza della parola che supera il tempo. Una voce rude fu quella da cui sentii recitare la prima volta alcuni versi dell’Odissea di Omero: “Musa, quell'uom di multiforme ingegno/Dimmi, che molto errò, poich'ebbe a terra/Gittate d'Ilïòn le sacre torri;/Che città vide molte, e delle genti/L'indol conobbe” .
Quando la vita diventa materia di canto è vita autentica. Nella cultura greca “solo ciò che il canto nomina esiste davvero”.
L’Odissea è un libro che mi accompagna da sempre, da quando, come dono per il Natale dei sei anni, ne ricevetti una edizione per l’infanzia.
“Qui più che in ogni altro libro sento respirare il mare, la volta stellata, la labirintica immensità del giorno che fugge”.
L’Odissea racconta il viaggio di ritorno (in greco nostos) del re di Itaca, Odisseo (Ulisse per i Romani), dopo la fine della guerra di Troia.
L’opera si apre in medias res e presenta uno splendido esempio di narrazione retrospettiva che dà anima e corpo al racconto.
Odisseo affronta diverse peripezie prima di toccare di nuovo “le sacre sponde” della sua patria: l’incontro con i Ciclopi, giganti monocoli, fra cui c’è il noto Polifemo, figlio di Poseidone; l’avventura con Eolo, Signore del vento, con i Lestrigoni, giganteschi mangiatori di uomini e con i due mostri marini, Scilla e Cariddi. Proverà il dolore della perdita dei compagni; la solitudine, l’angoscia, la disperazione.
Ma Ulisse possiede la Metis, ovvero “il sapere pratico, non teoretico”, la capacità di affrontare con l’ingegno e lo spirito di adattamento le situazioni più complicate e impreviste. Per questo supererà le prove più ardue. Nell’Odissea “l’areté non è più soltanto simbolo di forza, coraggio e onore, ma anche di astuzia e intelletto”. All’eroismo marziale di Achille, si sostituisce la versatilità di Odisseo, che ha fame di conoscenza, che vuole vedere ciò che solo immagina o intuisce. Così Dante immagina le parole di Ulisse ai compagni: “fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza” (Inf. XXVI, vv.119-120).
Ci sono molti momenti commoventi nell’opera, ma una delle scene più toccanti è l’incontro dopo vent’anni di assenza tra Ulisse e il proprio cane, Argo, ormai cieco, sdraiato su un mucchio di letame, straziato dalle zecche. Al cane basta sentire l’odore e la voce dell’amato padrone per sollevare la testa, rizzare le orecchie e muovere a festa la coda. Ha riconosciuto l’eroe, ma non ha neppure la forza di corrergli incontro. E allora, felice, muore.
Ulisse piange, commosso dalla purezza di quell’amore: “E in quel momento, quando sentì Odisseo vicino/mosse la coda e lasciò ricadere le orecchie;/non ebbe più forza di avvicinarsi al padrone./E quello, altrove guardando, si terse le lacrime (…) Argo il destino colse della nera morte/ appena ebbe rivisto Odisseo, dopo vent’anni”.
Nell’Odissea le figure femminili non hanno il ruolo di semplici comparse, ma sono ampiamente caratterizzate, così Atena, Circe, Calipso, Nausicaa e, soprattutto, Penelope. Quando, nella parte finale del poema, Penelope, che ha lungamente atteso il marito restandogli fedele, lo interroga non lo fa perché ignora ancora la sua identità, come superficialmente si potrebbe ritenere, ma perché vuole accertarsi “che il ragazzo che vent’anni prima l’amava sia ancora lì, davanti a lei, vuole sapere se ancora in quell’uomo si agita la furia sacra che la fece innamorare”.
Indimenticabili poi le parole che Achille rivolge ad Ulisse nell’Averno: “Preferirei essere il garzone dell’ultimo guardiano di porci piuttosto che regnare su questo popolo spento”.
L’Odissea è il viaggio della nostra anima verso l’ignoto; è lo scrigno di incontri e avventure che il destino ci riserva; è il dipanarsi di occasioni, sconfitte, rinunce, rimpianti e, al tempo stesso, il compiersi dei nostri talenti e del nostro ingegno; è il romanzo per eccellenza e la metafora per antonomasia dell’esistenza umana.
“Quando ti metterai in viaggio per Itaca/
devi augurarti che la strada sia lunga,/
fertile in avventure e in esperienze” (C. Kavafis, “Itaca”).

Commenta
Commenti